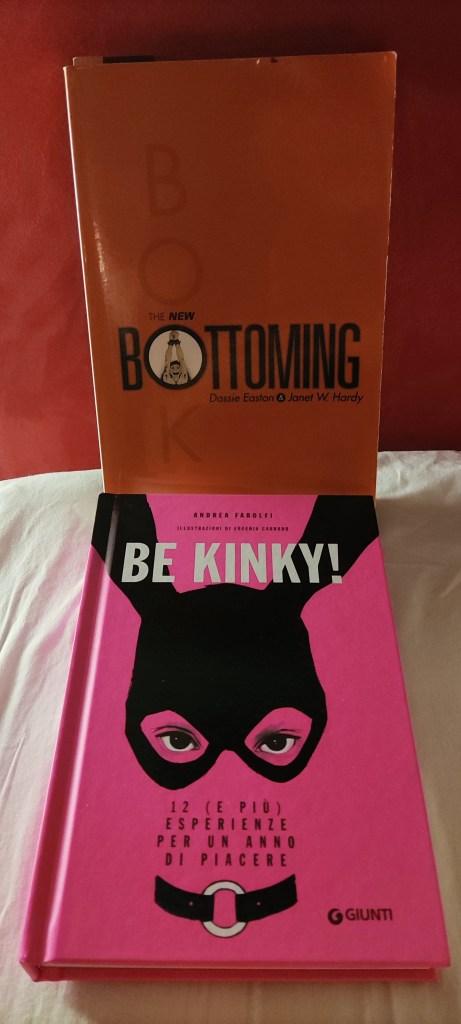Sono abbastanza competente da sapere che non sono abbastanza competente.
Conosco a sufficienza per sapere che non so tutto quello che dovrei sapere.
Sono dimagrita ma i vestiti non mi stanno ancora come vorrei.
Sono sufficientemente consapevole di me per comprendere che in alcuni aspetti mi manca ancora consapevolezza.
E’ come quando cercavo di farmi crescere i capelli: la maledetta mezza misura. Finché li avevo a spazzola erano comodi e stavano a posto; ora che li ho lunghi posso legarli, acconciarli, in un modo o nell’altro stanno a posto. Ma mentre crescevano avevo ciuffi scomposti, troppo corti per legarli ma troppo lunghi perché stessero giù, e per quante forcine, cerchietti e gel comprassi e usassi non c’era verso di trovare loro un aspetto decente.
Anche con la competenza, la consapevolezza e qualsiasi altra fase di passaggio è così: la mezza misura è la parte più difficile da gestire. Non è che non veda i progressi già fatti, ma paradossalmente mi fanno sembrare l’obiettivo ancora più distante da raggiungere. Nella mezza misura si tratta di resistere e passare oltre, sopportarla per attraversarla, senza cedere alla frustrazione (quante volte sono sbottata e mi sono tagliata di nuovo i capelli a spazzola perché non sopportavo più la mezza misura, e ho dovuto ricominciare dall’inizio?).
Ad un certo punto si scollina, lo so: poi tutto è in discesa, almeno fino alla prossima salita. Si tratta di tenere duro in un momento in cui la fatica sembra inutile.